Halloween e la pedagogia Waldorf: proteggere l’infanzia dal culto della paura
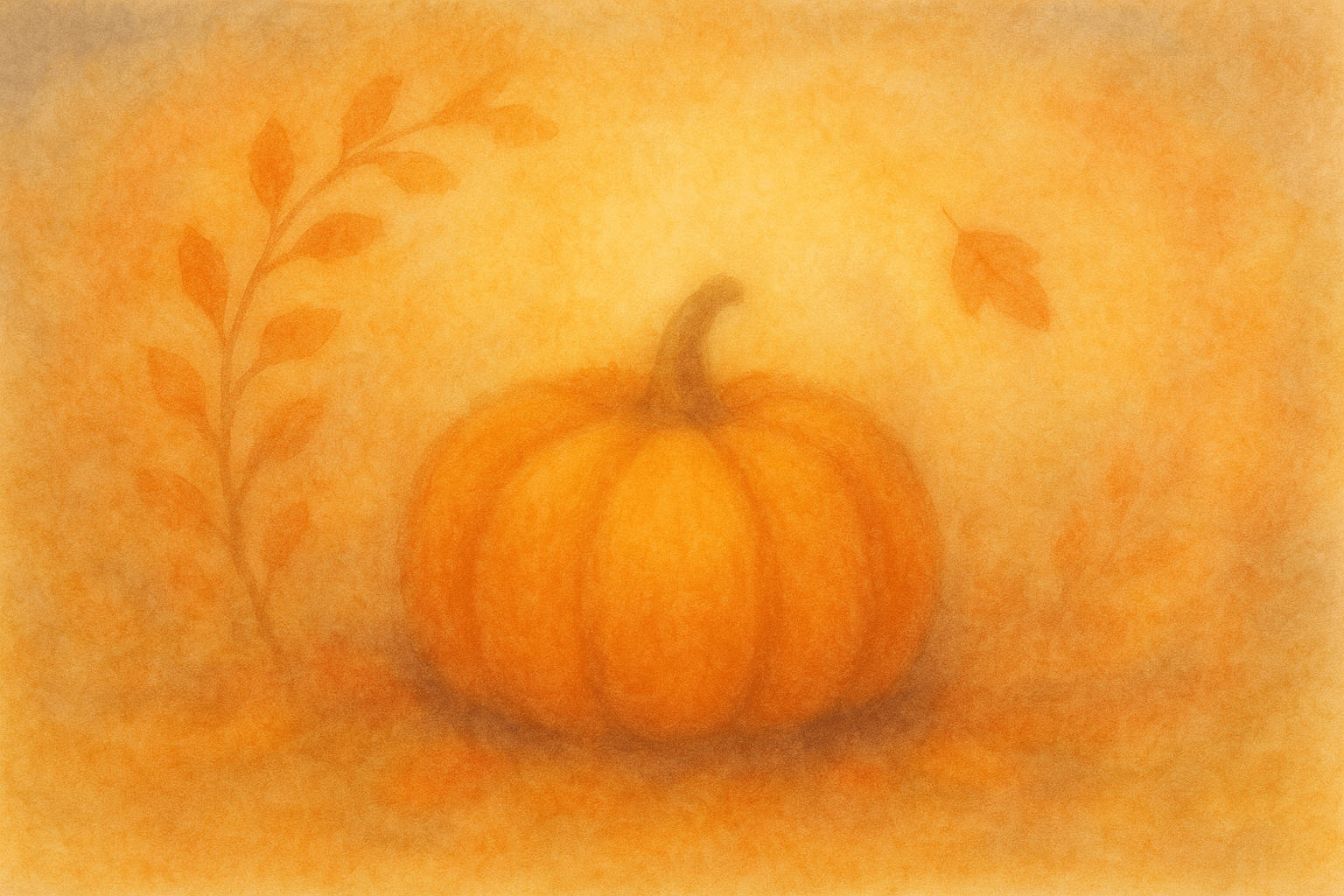
Una riflessione necessaria per educatori e genitori
Come educatori steineriani sentiamo la responsabilità di interrogarci su ciò che offriamo ai bambini, specialmente nei primi sette anni di vita. Halloween è diventato un fenomeno culturale pervasivo, ma raramente ci fermiamo a chiederci: cosa sta realmente vivendo un bambino piccolo di fronte a maschere mostruose, ambientazioni horror e celebrazioni del terrore?
La degenerazione di un’antica tradizione
L’attuale Halloween è la degenerazione commerciale di antiche tradizioni sacre. Il Samhain celtico, celebrato tra il 31 ottobre e il 1° novembre, segnava il passaggio dall’estate all’inverno e rappresentava un momento in cui il confine tra mondo visibile e invisibile si assottigliava. Era un tempo di raccoglimento, di bilancio, di preparazione interiore.
Il Cristianesimo non cancellò questa sensibilità spirituale, ma la trasfigurò in una visione più alta: il 1° novembre divenne Ognissanti, festa che celebra la comunione con gli esseri spirituali che hanno vissuto nella luce e nella virtù. Il 2 novembre, la Commemorazione dei Defunti invita a mantenere vivo il legame d’amore con chi ha attraversato la soglia della morte. Questa sequenza sacra trasforma il buio autunnale in un cammino di luce interiore.
Cosa è accaduto invece con Halloween? Un processo di commercializzazione e volgarizzazione ha ridotto il mistero della soglia tra mondi a uno spettacolo di orrori, dove la morte non è più trasformazione ma grottesco, dove il sacro è diventato parodia. Non è una festa: è rumore che copre il silenzio necessario per ascoltare i movimenti profondi dell’anima in questo tempo dell’anno.
Il bambino piccolo: un essere ancora tra due mondi
Rudolf Steiner ci ha insegnato che nei primi sette anni di vita il bambino vive in una condizione particolare. Non è ancora completamente “arrivato” sulla terra. Porta ancora in sé un’eco dei mondi spirituali da cui proviene. La sua anima è aperta, permeabile, sensibile a tutto ciò che lo circonda.
Per questo motivo, il bambino piccolo non distingue tra realtà e fantasia come fa un adulto. Ciò che vede, lo vive. Ciò che incontra, lo assorbe. Il mondo esterno diventa mondo interiore senza filtri, senza difese.
Quando un bambino del primo settennio incontra immagini di terrore, non le “guarda” semplicemente: le beve, le respira, le incorpora. Quelle immagini lavorano nel profondo, creando paure che non possono essere verbalizzate né comprese, ma che si depositano nell’organismo e nell’anima, talvolta per anni.
Cosa significa educare all’immagine
Nella pedagogia Waldorf, l’educazione attraverso l’immagine è centrale. Ma non qualunque immagine: immagini che siano vere, belle, buone. Immagini che nutrano la fiducia del bambino nel mondo, che rafforzino la sua volontà, che lo aiutino a dire “sì” alla vita.
In L’educazione del bambino alla luce della scienza dello spirito Steiner spiega che ciò che il bambino vive nei primi anni diventa costituzione del suo corpo. Se questo è vero, quale corpo stiamo costruendo esponendo i bambini a zombi, mostri, sangue, grida? Quale anima stiamo formando se il primo incontro con il tema della morte è attraverso la sua deformazione grottesca?
L’educatore steineriano sa che ogni gesto, ogni colore, ogni suono conta. Per questo sceglie con cura le fiabe, i giochi, le canzoni. Per questo crea ambienti dove la bellezza non è decorazione, ma nutrimento.
Le autentiche feste d’autunno: un cammino di luce nel buio
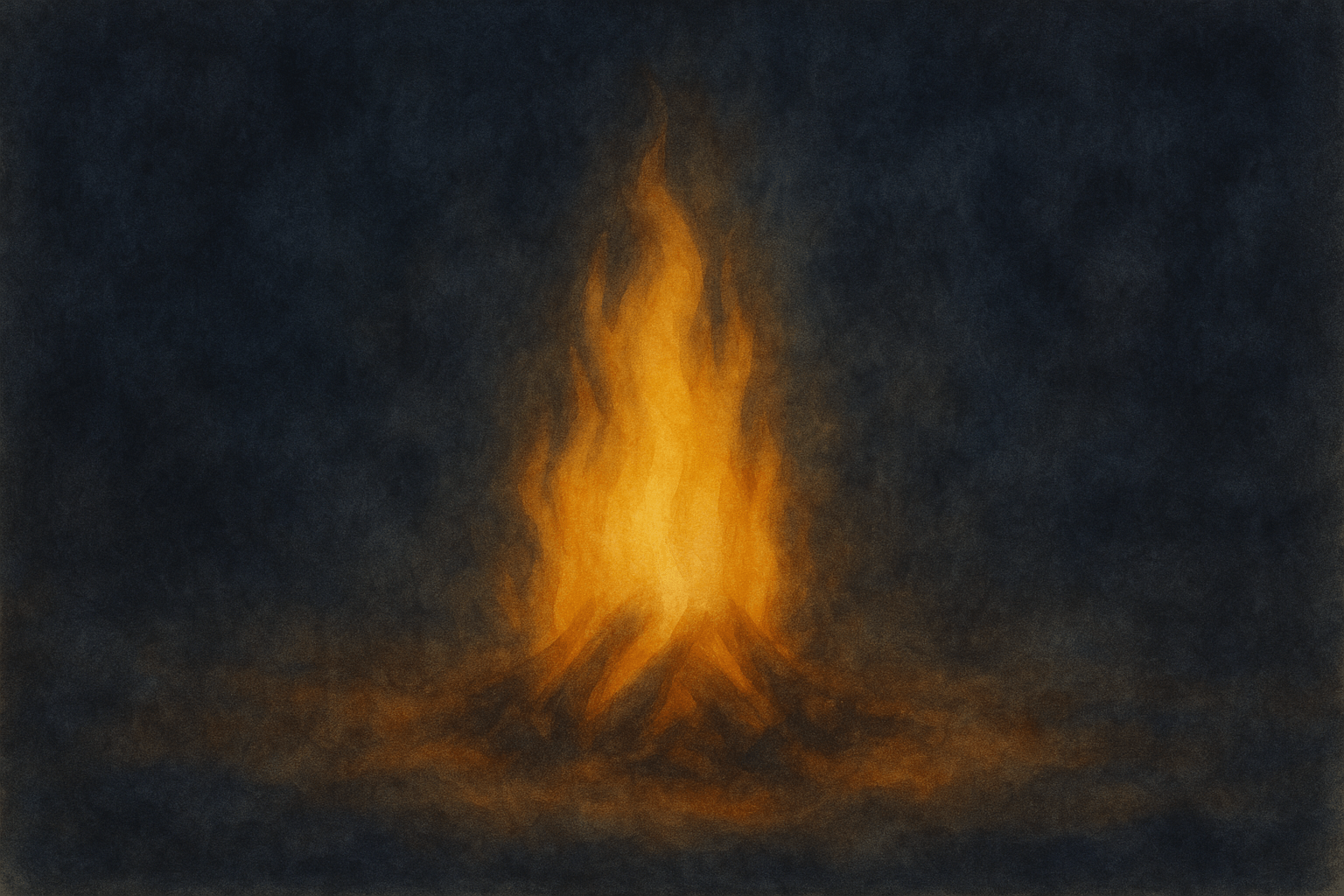
La pedagogia Waldorf non propone alternative ad Halloween, perché le vere feste autunnali esistono da sempre nella tradizione spirituale europea. Halloween è l’intruso, non San Michele o San Martino.
La festa di San Michele (29 settembre) apre l’autunno con l’immagine dell’arcangelo che affronta il drago. Non è violenza, ma coraggio. Non è paura, ma forza interiore. Michele rappresenta l’equilibrio tra cielo e terra, la capacità dell’essere umano di portare luce anche quando le forze oscure sembrano prevalere. I bambini vivono questa festa attraverso giochi di coraggio, racconti di eroi, attività che richiedono determinazione.
La festa di San Martino (11 novembre) porta l’immagine della lanterna che il bambino stesso costruisce e accende. Martino è colui che divide il mantello, che dona calore, che non chiude il cuore di fronte al bisogno. La lanterna diventa simbolo: ognuno di noi porta una luce interiore che può illuminare la strada anche nel buio più fitto dell’inverno che avanza.
Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti possono essere vissute con i bambini più grandi come momenti di raccoglimento: accendere una candela per un nonno, raccontare storie di persone amate che non ci sono più, preparare fiori per le tombe. La morte non viene nascosta, ma nemmeno spettacolarizzata: viene accolta con dignità, rispetto, amore.
Queste feste formano nell’anima del bambino immagini di speranza, trasformazione, gratitudine. Lo accompagnano nel ritmo dell’anno come in un respiro: espansione nella luce estiva, raccoglimento nell’interiorità invernale.
Il tempo del raccolto: gratitudine invece di paura
L’autunno è il momento in cui la natura offre i suoi ultimi frutti prima del riposo invernale. Castagne, mele, zucche, pannocchie: tutto parla di abbondanza, di dono, di chiusura di un ciclo.
Nelle scuole e nei gruppi steineriani, il tavolo delle stagioni si riempie di questi tesori. I bambini toccano, annusano, assaggiano. Imparano la gratitudine verso la terra che nutre.
La zucca può essere presente, certo, ma non intagliata con volti spaventosi. Per i più piccoli, meglio lasciarla intera: la sua rotondità piena trasmette sicurezza. Per i più grandi, si può intagliare con forme luminose: stelle, lune, fiori. La zucca torna così ad essere ciò che è: frutto del raccolto, contenitore di luce, simbolo di abbondanza.
Non servono maschere per vivere l’autunno. Servono gesti semplici, veri, radicati nel ritmo della natura e dell’anima.
Una scelta controcorrente ma necessaria
Sappiamo che non è facile sottrarsi ad Halloween. I bambini vedono vetrine decorate, amici mascherati, dolcetti a forma di fantasma. La pressione sociale è forte. Eppure, come educatori e genitori, siamo chiamati a una scelta coraggiosa.
Non si tratta di proibire, ma di offrire qualcosa di più vero, di più profondo. Non si tratta di isolare i bambini, ma di proteggerli da ciò che non sono ancora pronti a metabolizzare.
Thomas Homberger, nel suo testo Il bambino nell’epoca dei media, ci ricorda che ogni esperienza lascia un’impronta. Sta a noi scegliere quali impronte vogliamo che si formino nell’anima e nel corpo dei nostri bambini.
Educare alla luce è un atto d’amore
Il bambino che cresce nella pedagogia Waldorf impara che il mondo è buono, che la vita ha senso, che la bellezza esiste. Questo non significa negare il dolore o la morte, ma accoglierli nel momento giusto, con le immagini giuste, nel modo giusto.
La morte nella pedagogia steineriana è soglia, non fine. È trasformazione, non annientamento. È mistero, non orrore.
Offrire ai bambini piccoli un’infanzia protetta, nutrita di immagini sane, non è debolezza: è saggezza. È dare loro la possibilità di costruire radici forti, che domani permetteranno loro di affrontare anche le esperienze più difficili con equilibrio interiore.
In questo tempo dell’anno, possiamo accendere lanterne invece di comprare maschere. Possiamo raccontare fiabe di coraggio invece di storie horror. Possiamo preparare dolci insieme, visitare le tombe con rispetto, ringraziare la terra per i suoi doni.
Possiamo scegliere la luce. Non come fuga dal buio, ma come forza che attraversa il buio e lo trasforma.
Questa è la nostra responsabilità come educatori. Questa è la nostra scelta come adulti che accompagnano l’infanzia.
Per approfondire
- Rudolf Steiner, L’educazione del bambino alla luce della scienza dello spirito
- Rudolf Steiner, La relazione con i nostri cari defunti, Editrice Antroposofica
- Geoffrey Keating, Foras Feasa ar Éirinn (“Storia d’Irlanda”)
- Thomas Homberger, Il bambino nell’epoca dei media
- Cristina Laffi, Alla ricerca delle origini di Halloween, Scuola Steineriana M. Garagnani




